

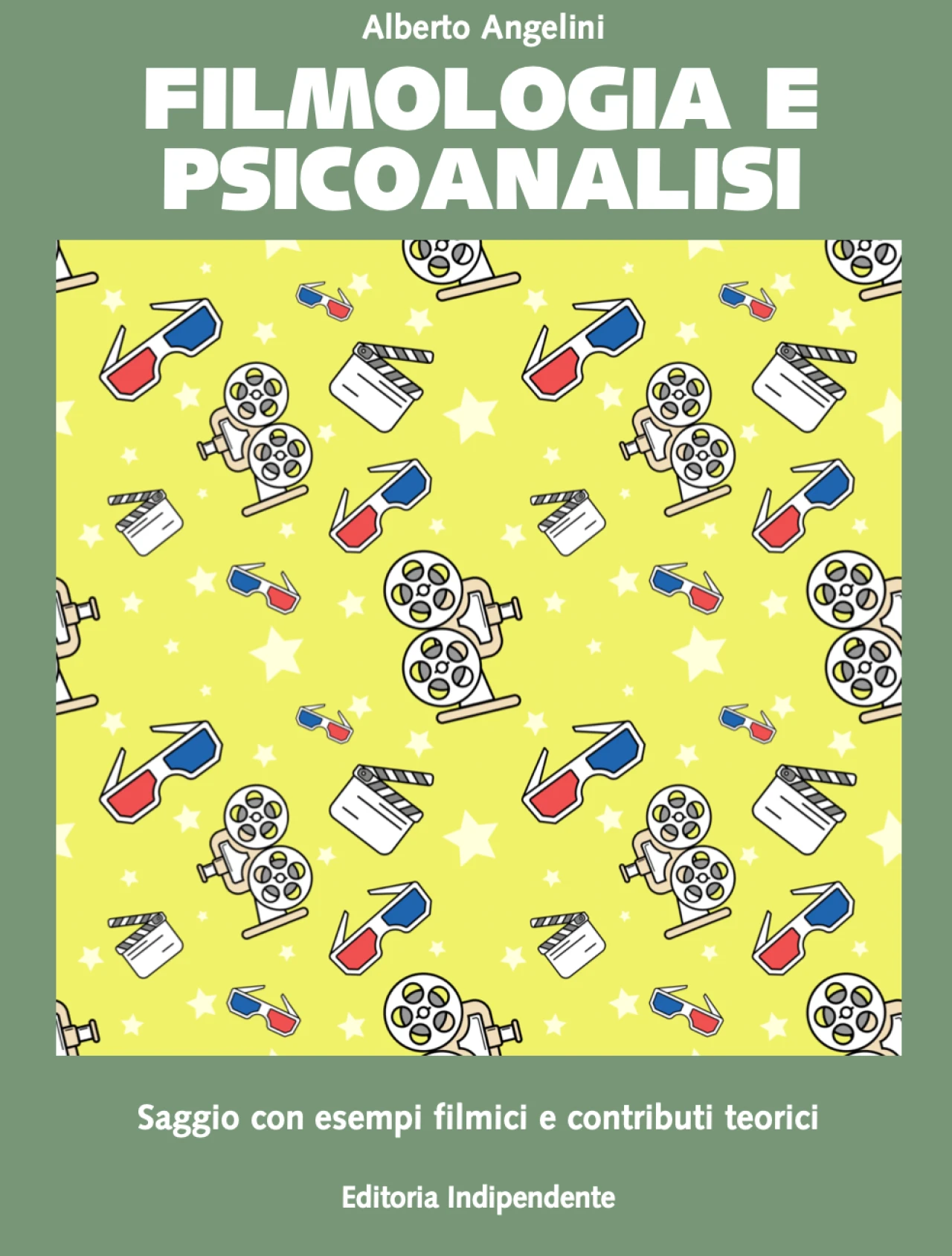
Cinema e Amori
Eidos-News
La filmologia nasce nel contesto culturale francese, alla metà del Novecento. Indimenticabili personaggi parteciparono all’esordio: Georges Sadoul, André Bazin, Edgar Morin e in seguito Roland Barthes. In ambito psicologico: Henri Wallon, con i coniugi Bianka e René Zazzo. Per la psicoanalisi: Cesare Musatti, Didier Anzieu e Serge Lebovici. I primi studi furono pubblicati sulla Revue internationale de filmologie, diretta da Gilbert Cohen-Séat, dal 1947 fino al 1961. Purtroppo, in quel periodo di guerra fredda, i contributi russi sul cinema faticavano a raggiungere l’occidente. Le idee di personalità come il regista Sergej Ejzenštejn, lo psicologo Lev Vygotskij e altri sovietici si diffusero pienamente solo nella seconda metà del secolo. Storicamente, tuttavia, va riconosciuto a Lou Andreas Salomé il primo pensiero riflessivo sul cinema. Ella, già nel 1913 mentre seguiva a Vienna le lezioni e i dibattiti dell’Associazione psicoanalitica, annotava nel suo diario come solo la tecnica cinematografica permettesse una rapidità di successione delle immagini in grado, più o meno, di corrispondere alle “nostre facoltà di rappresentazione”, imitando anche la “versatilità” delle medesime.
La filmologia studia il cinema utilizzando saperi complessi. Da una parte si distingue il fatto filmico, dove vengono analizzati i contenuti interni, artistici e psicologici dell’opera. In ciò è essenziale la prospettiva psicoanalitica. Ogni studioso, nei film come nei casi clinici, utilizza le proprie personali tipologie d’analisi, suscitando anche problemi metodologici. Ma per uno psicoanalista è impossibile sottrarsi. D’altra parte, si designa il fatto cinematografico, che analizza anche gli aspetti filosofici, sociologici, psicologici, etici e via dicendo del complessivo contesto audiovisuale, senza dimenticare la psicofisiologia e la stessa tecnologia cinematografica. Qui l’indagine è spontaneamente multidisciplinare, sperimentale e dialettica. La comparsa del web e dei social media ha avviato l’elaborazione di un nuovo discorso.
Dopo l’inedito saggio introduttivo, il volume contiene altri più brevi contributi teorici su temi particolari. Con una scrittura accessibile si esamina, nel cinema, la psicologia dello spettatore, lo sport, la fantascienza, l’aggressività, la dipendenza, il progresso, la storia, toccando anche autori specifici, come Hitchcock e Warhol.
Dalla prospettiva psicoanalitica e dei contenuti ideali vengono valutati ventisei film, più due serie televisive, Fauda (2015) e Ozark (2017). È un panorama che va dal genere storico di Braveheart (1995) a quello drammatico di Gran Torino (2008), con attenzione ai temi sentimentali, come in Emotivi anonimi (2010), o ne La vita di Adele (2013). Sono presenti incursioni nel perturbante come il classico Mulholland drive (2001) e nel romanzo di formazione, come The Tender Bar (2021). I quattro film italiani, che compaiono nella rassegna, riguardano sostanzialmente la commedia.
Vedi tutto il numero