

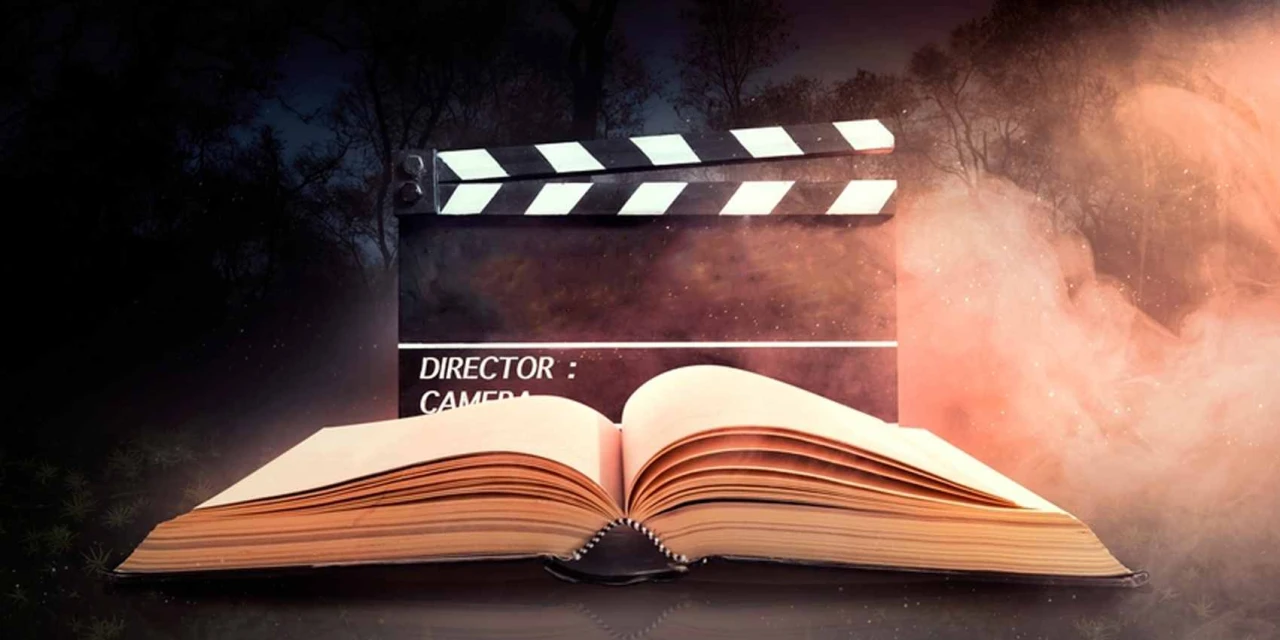
Cinema e Amori
Approfondimento
Il film più antico fu proiettato nella caverna di Platone. La filosofia ama il cinema per motivi profondi. Dalla fine dell’Ottocento, la maggiore vittoria della filosofia, nel modo inaugurato da Nietzsche e ispirato a Schopenhauer, è aver rimesso in questione la razionalità esclusivamente logica con la quale il filosofo affrontava abitualmente il mondo, per introdurre nel processo di comprensione del reale anche l’affetto. La psicoanalisi va considerata come la maggior protagonista attiva di questa trasformazione. Il cinema, coevo nello sviluppo al pensiero psicoanalitico, ha offerto la migliore forma artistica per esprimere questo connubio.
Al pari delle proposizioni linguistiche, l’immagine cerca di imporsi come verità, ma è più potente. Un disegno, dicevano gli alchimisti arabi, è più forte di mille parole. Mai argomenti puramente logici sono stati capaci di penetrare nel nucleo di ciò che è reale, senza un aiuto da parte di ciò che è sensibile. Il cinema, come ogni arte, non afferra mai completamente la realtà, ma ci riesce un pò e a volte tanto, rovesciando il meccanismo della deduzione aristotelica. Per cui, quando esiste quel connubio fra ragione e affetto profondo, di cui parlava Sergej Ejzenštejn pensando alla psicoanalisi, una finzione particolare riesce ad avere a che fare con una verità universale. Nel cinema dobbiamo emozionarci per capire, anche se non accettiamo la proposta. L’Hitler de La Caduta ci emoziona, permettendoci di capire, anche se non ci commuoviamo per lui e non lo accettiamo. Così, attraverso mille esempi, dai film trasudano le più grandi storie mai raccontate, che non appartengono ai professori. La storia di Socrate, come quella di Gesù, dovrebbe essere narrata nei libri per ragazzi; dovrebbe essere tema di discussione a scuola e in famiglia. Dovrebbero farci tanti film, come a suo tempo cercò di fare Roberto Rossellini.
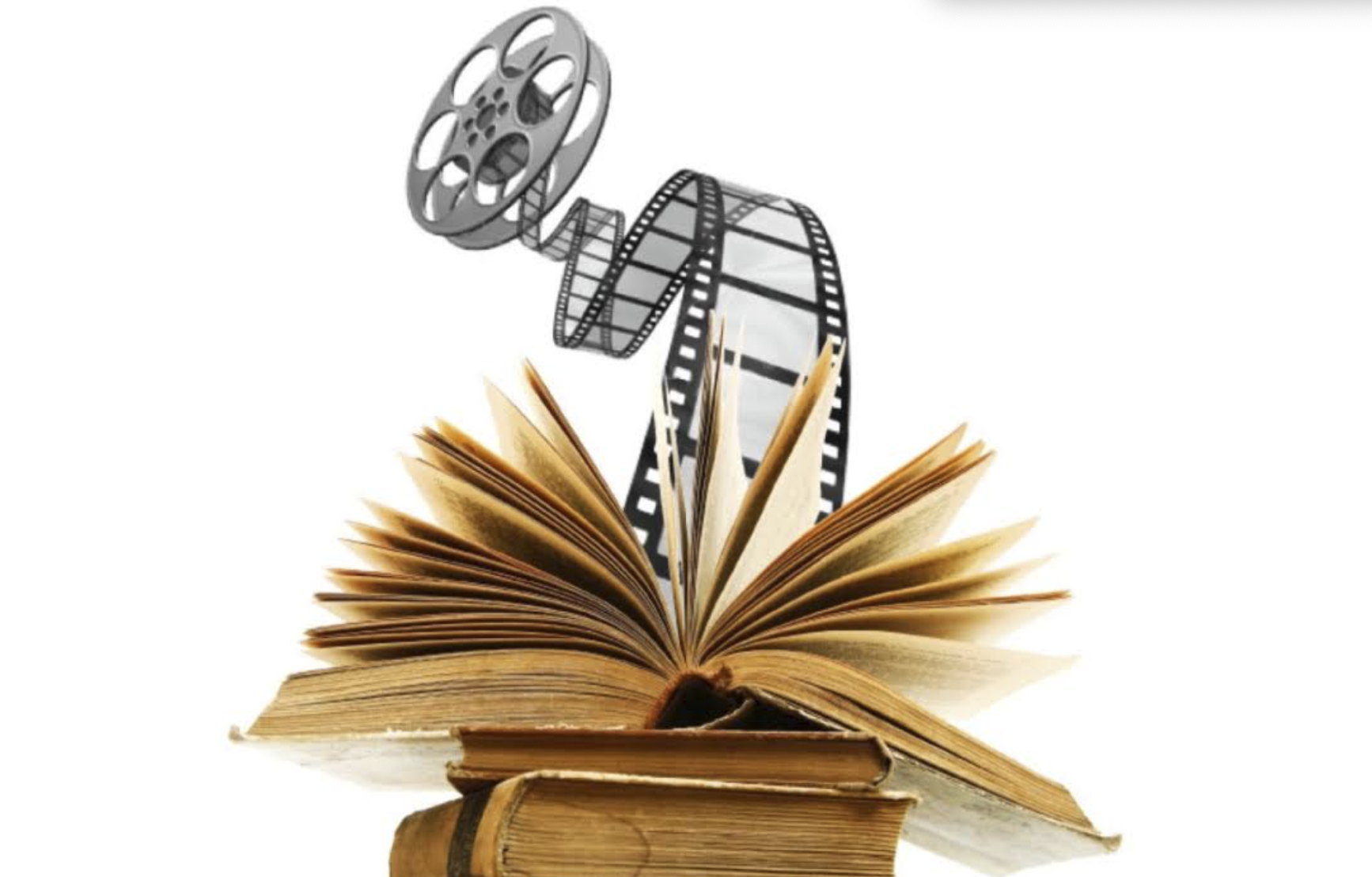
Ma anche il cinema ha i suoi motivi privilegiati. Per esempio: l’inverosimile, il fantastico, la natura scatenata, l’eroismo senza gloria, l’incertezza, l’ingiustizia, la violenza, l’incomunicabilità e così via. Indipendentemente dallo specifico, le costanti di base appaiono di questo tipo e ciò che è del tutto positivo non ha alcun interesse. È lo straordinario, il sorprendente a scuotere l’occhio del cinema, anche quando lo straordinario riguarda il quotidiano, come nei film di Antonioni e Wenders. L’immagine cinematografica non può mostrare senza rendere problematico, ristrutturare, distorcere e rielaborare. Differentemente da quel che pensavano i neorealisti italiani, il cinema è tutto tranne che una “pura registrazione del reale”. La caratteristica principe dell’attività cinematografica risulta essere proprio la capacità perturbatrice della sua “illusione di realtà”, che può rappresentare qualsiasi cosa, anche ciò che di più fantastico e inverosimile possa esserci. Tutto diventa per un pò credibile, in modo retorico, ammaliante e a volte sfacciatamente bello e bugiardo, come ne Il favoloso mondo di Amélie.
La filosofia, invece, vorrebbe mantenere un atteggiamento sempre sobrio e riverente nei confronti della verità e della conformità al reale. Però, anche la filosofia più analitica e razionalista ammette la legittimità del ricorso alla fantasia o a esempi bizzarri per chiarire limpidamente problemi filosofici urgenti. Si pensi al “Genio maligno” di Cartesio, che incarna il dubbio metodico e iperbolico, o all’esperimento mentale dei mondi gemelli di Hilary Putnam che dimostra come la storia causale di una persona sia più importante dei contenuti del suo cervello. In filosofia, proprio come nella psicoanalisi si accetta tranquillamente che il cammino verso la verità e l’universalità possa essere molteplice e paradossale. Si crede che sia possibile conoscere qualcosa del mondo e delle persone sia perseguendo la verità, sia utilizzando l’immaginazione e supposizioni inconsuete.
Nel cinema la voglia di universalità e verità è costruita con un impatto emotivo. Il film prevalentemente è un “colpo basso”, non un messaggio sobrio. Le sue immagini traboccano emozioni, arrivando al cervello; per questo riescono a toccare rapidamente le questioni principali, molto più di quanto potrebbe farlo un misurato scritto filosofico o psicoanalitico. La maggior parte delle cose esposte cinematograficamente sono già state dette o scritte con altri mezzi; ma chi arriva a conoscerle tramite il cinema viene chiamato in causa in modo diverso. Non è lo stesso dire a qualcuno che la guerra è assurda, o fargli vedere Nato il 4 luglio. Le storie del cinema hanno effetti diversi da quelle raccontate o scritte.
Con le storie emergono gli amori, essenziali anche per chi ama prima di tutto la sapienza. Amori inaspettati e tenaci, come quando i Blues Brothers dicono “Siamo in missione per conto di Dio”, possedendo solo una tanica di benzina, mezzo pacchetto di sigarette e lontani 106 miglia da Chicago. Una vera determinazione richiede amore. Anche Socrate, come ogni vero filosofo, che non è un titolo accademico, era in missione. La stessa missione in fondo de L’uomo con la macchina da presa di Vertov: vedere e capire con la cinepresa, anche dove l’occhio umano non riesce ad arrivare. Il cinema dei registi appartiene anche ai filosofi e, perché no, agli psicoanalisti; ma sono tre categorie che si assomigliano. Nessuno può specializzarsi fino in fondo in queste discipline. L’Altro psicoanaliticamente non potrà mai corrispondere al bisogno assoluto da cui costoro, ma non sono i soli, si sentono irresistibilmente attratti. Anche in questo caso trionfa quella mancanza che, per Platone, è l’alimento del desiderio e del vero amore.
Vedi tutto il numero